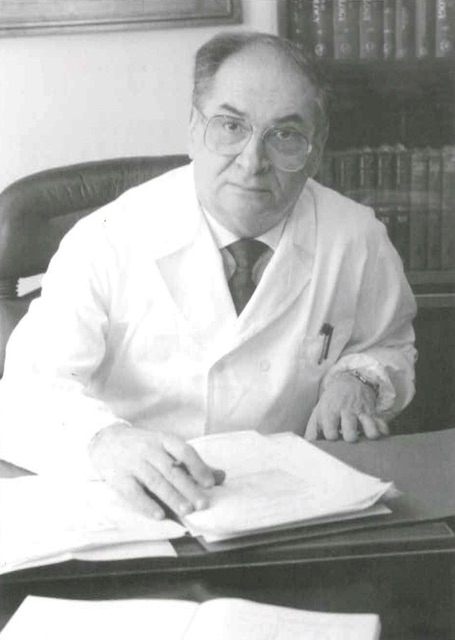Ricordo di Angelo Burlina nel 25° della scomparsa
04/11/2018
Nel pomeriggio uggioso di una giornata autunnale, il 25 ottobre del 1993, mentre terminavamo le nostre routine o preparavamo poster e relazioni per l’imminente Congresso, la notizia si diffuse rapida quanto allora consentiva il telefono: il professor Burlina era morto… probabilmente come avrebbe voluto … nel suo laboratorio, tra i suoi libri e suoi strumenti di ricerca, tra i suoi collaboratori e i suoi allievi…
Sentimenti contrastanti si affollarono nelle nostre menti, ma, sopra tutti, l’incredulità, per l’energia con cui il professore continuava la battaglia professionale e scientifica e per il gusto della vita che sempre dimostrava (per esempio due giorni prima al suo compleanno!), e lo sgomento, perché ci rendevamo conto con grande lucidità, in quel momento, della sua insostituibilità e della sua grandezza come fondatore della Medicina di Laboratorio italiana - non tanto o non solo della società scientifica ma soprattutto della disciplina Medicina di Laboratorio - nome che oggi tutti portano addosso ma che allora era la scoperta (o forse una sua vera invenzione) di una disciplina visionaria e in qualche modo eretica.
Angelo Burlina era nato il 23 ottobre del 1926 a Motta di Livenza e, come il suo grande predecessore e conterraneo l’anatomico Antonio Scarpa, si laureò a Padova nel 1952 e qui si specializzò in Anatomia ed Istologia Patologica (1963), Isto e Citochimica (1964) e Chimica Clinica (1968), maturando lì l’idea di una continuità e di una necessaria sintesi tra le grandi discipline mediche della tradizione e le nuove prospettive della medicina di laboratorio.
La sua vita professionale raccolse gli stimoli delle esperienze cliniche, della scuola anatomica patavina, del laboratorio in cui servì in particolare a Conegliano e a Verona, per approdare alla cattedra di Biochimica Clinica alla sua Università di Padova, dove fu anche Direttore della Scuola di Specialità in Patologia Clinica e Primario del Laboratorio Ospedaliero.
Le sue ricerche spaziarono in molti campi tra cui, in particolare, in enzimologia clinica, sui marcatori tumorali, intorno ai fondamenti di gestione del laboratorio, sulla standardizzazione e sul controllo di qualità per oltre 700 pubblicazioni nazionali ed internazionali e furono la base, insieme con le riflessioni e le elaborazioni teoriche sulla Medicina di Laboratorio, dei suoi grandi libri in enzimologia, biochimica clinica e soprattutto, negli anni ottanta del secolo scorso, della serie di libri che fondarono la medicina di laboratorio italiana, dal meraviglioso, anche iconograficamente (passione che sempre lo caratterizzò), “Introduzione alla Medicina di Laboratorio” del 1982 al “Medicina di Laboratorio - Fondamenti di diagnostica” del 1992 (l’americano Mario Werner lo indicò come il più bel libro mai scritto nel campo), passando per “La logica diagnostica del Laboratorio” del 1988, dove scolpiva le radici, gli obiettivi e le prospettive della medicina di laboratorio come risposta teorico-pratica al quesito clinico.
La sua vita fu fatta di attività scientifiche e formative fortemente sociali, com’era nella sua natura e nel suo carattere, esplicandosi in attività societarie – fondatore e presidente della Società di Enzimologia Clinica, della Triveneta di Patologia Clinica, della Società Italiana di Medicina di Laboratorio (dal 1986 alla morte) e presidente dal 1975 al 1981 della Associazione Italiana di Patologia Clinica; componente di WASP dal 1993; attività editoriali – fondatore e direttore di LAB, Progressi in Medicina di Laboratorio, Medicina di Laboratorio e European Journal of Laboratory Medicine; componente degli Editorial Board di Clinical Biochemistrye Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences; attività operative – come membro dello “Standardization Committee of the International Union of Immunological Societies” (1977 to 1987) e Co-Chairman dello “Standardization and Enzyme Commission of the World Association of Societies of Pathology”; e come fondatore di CISMeL (Comitato per la Standardizzazione dei Metodi Ematologici e di Laboratorio) e del Centro di Ricerca Biomedica (CRB) di Castelfranco Veneto ora Centro di Ricerca Biomedica per la Qualità in Medicina di Laboratorio in Padova.
Nella sua ultima prolusione, quella che non riuscì a leggere e che al suo posto lesse il suo allievo, successore e amico Ugo Lippi al Congresso Nazionale di Trieste 3 giorni dopo la sua morte, egli diceva “è giunto il momento che, quanto più dignitosamente possibile, io provveda a concludere il ciclo dell’impostazione culturale e professionale iniziato nel 1986” ed enumerava i passaggi di quel percorso - oggi lo riconosciamo pienamente - fondativo della disciplina: il percorso formativo della medicina di laboratorio; etica e formazione come base della professione; la “nuova” logica diagnostica del Laboratorio; la tecnologia come fattore costitutivo e di progresso; i fondamenti della gestione del Laboratorio; il rapporto con l’industria; la qualità o meglio “la visione olistica della qualità globale” (gli aggettivi non sono scelti a caso!); per finire, traslando in italiano moderno le parole di Galileo “noi quindi sviluppiamo una scienza nuova su di un oggetto antichissimo”.
La conclusione di quello scritto è quanto mai attuale e in qualche modo profetica e va ascoltata ancora oggi.
“La mia lettura di questa sera non si è però limitata alla qualità, perché ho parlato dei fondamenti della diagnostica di laboratorio, di temi gestionali scottanti e di prospettive di progresso tecnologico. Mi vien fatto di chiedermi … se negli argomenti che ho trattato e nel modo in cui li ho trattati vi è una sufficiente carica di speranza …”
“Consapevole che il compito dei vecchi è preparare il nuovo per quelli che verranno, ritengo di aver dato un messaggio semplice ma imperativo, riassumibile pragmaticamente in queste parole: lavoriamo per espandere la scienza e per gestire la pratica. So che questa esortazione cade in un momento che vede principi morali infranti e buone intenzioni messe a dura prova; caratterizzato da mancanza di pace sociale e di slancio economico, da mancanza quindi di quell’interazione tra fattori sociali e fattori scientifici che ha reso possibile nei secoli lo sviluppo della medicina; che occorrerebbero segni più tangibili della nostra importanza e della nostra “indispensabilità” perché la società ci guardasse con maggior attenzione. Ma sono miserie che non dipendono da noi, o almeno solo per piccola parte; da noi dipendere vivere con speranza la pienezza del tempo e del ruolo in cui siamo coinvolti ”…
“Ma il tipo di speranza che io intendo non è sicuramente quello di ultima dea. Se ci serve una identificazione precisa, senza irriverenza affermo che è la speranza in senso teologale: è la certezza, la fede in quello che sappiamo e possiamo fare e nei risultati che legittimamente ci aspettiamo. Chi avesse intravisto nelle mie parole la speranza dei disperati si è sbagliato, perché abbiamo la forza delle idee, l’umiltà di chi sa di avere ancora e sempre tanto da imparare e professionalità sufficiente per proporci obiettivi di alto profilo e raggiungerli con successo.”
Ancora grazie, Maestro…
Piero Cappelletti
Il ricordo di Angelo Burlina è stato letto da Piero Cappelletti in occasione del 4° Congresso Nazionale SIPMeL (Catania 23-25 ottobre 2018)